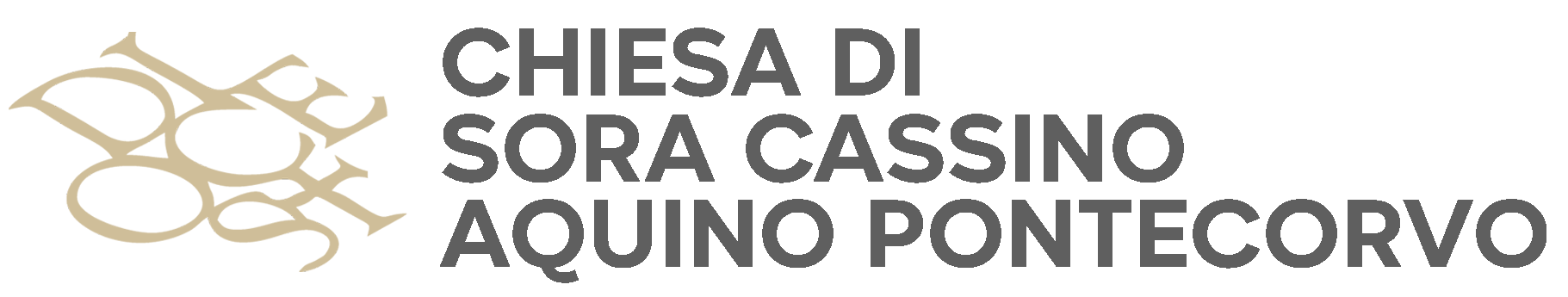RELAZIONE SEMINARIO TEOLOGICO-PASTORALE
24 gennaio 2025 – Cassino, Parr. S. Giovanni Battista
Mons. Gerardo Antonazzo
PROFEZIE DI SPERANZA
“Vino nuovo in otri nuovi”
“Io faccio nuove tutte le cose”
Premessa
La vocazione cristiana si fa con-vocazione assembleare, perché la dimensione comunitaria della fede in Gesù è fulcro vitale e dinamico dell’essere Chiesa di Gesù, comunità del Signore risorto. Ogni vita spirituale vive del soffio aspirante della fede personale e del soffio inspirante della vita comunitaria. E’ questo il valore esemplare anche del nostro convenire oggi in assemblea insieme al Vescovo.
Il vangelo della chiamata dei Dodici, celebrato nella liturgia odierna1, consegna la chiamata personale e la dimensione comunitaria dello stare insieme intorno a Gesù. Marco racconta una storia al singolare quando inizia a redigere il suo testo annunciando: “Vangelo di Gesù Cristo…”, per parlare di un uomo speciale, ma allo stesso questa storia diventa plurale, “come a dirci: il nome di Gesù può essere pronunciato correttamente solo se messo accanto a quello dei suoi amici, la sua vita si può raccontare solo se diventa vita di una comunità. Il Vangelo di Gesù Cristo si apre a chi sa scorgervi una storia plurale, non le gesta e le parole di un superuomo”2.
E’ questo, miei cari amici, il primo vero segno profetico del nostro essere Chiesa. E’ quanto crediamo celebrando la liturgia eucaristica: “Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa [che è a Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo]. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Gerardo e tutto l’ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia”3.
Da dove veniamo?
Per dare un’anima vissuta alla nostra Assemblea porgiamo il desiderio e favoriamo il valore prezioso dell’incontro, dell’ascolto e dialogo. Spero che quanto il Signore oggi ci chiede di annunciare e considerare con la sapienza del cuore, nel suo nome e alla sua presenza, sia vissuto da me e da voi con la forza del suo Spirito, e che sia perciò parola di profezia e di speranza.
Dopo i primi due anni indicati e proposti come FASE DI ASCOLTO (il primo anno, ascolto intraecclesiale con i gruppi sinodali; il secondo anno ascolto extramoenia, con i Cantieri dei villaggi), siamo approdati alla FASE SAPIENZIALE (discernimento sull’ascolto esercitato). In questa percorso sapienziale ogni diocesi ha presentato al Comitato nazionale del Cammino sinodale alcune proposte di rinnovamento ecclesiale secondo le “condizioni di possibilità”, nel contesto culturale e sociale di un vistoso cambiamento epocale: culturale (stili di vita), sociale, etico-morale, spirituale e religioso.
A partire dalle proposte delle Chiese che sono in Italia, il Comitato nazionale ha elaborato il testo dei LINEAMENTI4 inviati ai Referenti diocesani. Facendo riferimento a questo testo, quali abbiamo lavorato nella Prima Assemblea sinodale nazionale svolta nei giorni 15-17 novembre 2024 a Roma. L’Assemblea nazionale è stato un evento nel quale lo Spirito ha suscitato un profondo respiro ecclesiale felicemente partecipato, sereno e franco, umile e dialogico, anche coraggioso secondo la parresia dello Spirito. L’intenso e appassionato lavoro dei tavoli sinodali, ha visto la compresenza di circa mille referenti tra Vescovi, Consacrati, Presbiteri, Diaconi, e Laici.
Il Cammino sta mettendo in evidenza quanto la relazione che lega i membri della comunità cristiana sia l’amicizia fiduciale, animata dalla presenza dello Spirito di Dio che agisce su tutte le componenti ecclesiali, anche nelle sue forme ed espressioni istituzionali, ma non burocratiche, tra le quali il Sinodo mondiale dei Vescovi, la Conferenza episcopale italiana, il Comitato nazionale del Cammino sinodale, i nostri Organismi di partecipazione, i Referenti diocesani del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, l’Assemblea sinodale nazionale, questo nostro Seminario Teologico-pastorale, lo Strumento di lavoro con il quale saremo impegnai a misurarci e a confrontarci, etc. Se ho deciso di presentare in prima persona i contenuti del nostro Seminario teologico-pastorale è perché siamo giunti ormai a quella strettoia provvidenziale attraverso cui il Cammino sinodale in comunione con le Chiese che sono in Italia, si fa progressivamente nei prossimi anni SINODO DIOCESANO.
Segno di speranza o illusione ottica?
Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo “Pellegrini di speranza” scrive: “Oltre ad attingere la speranza nella grazia di Dio, siamo chiamati a riscoprirla anche nei segni dei tempi che il Signore ci offre. È necessario, quindi, porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi, che racchiudono l’anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza”5.
Ma se non sappiamo abitare il “tempo dei segni”6, faremo molta fatica a riconoscere i “segni dei tempi”, e trasformarli in “segni di speranza”. Solo se lo diventerà, il Cammino sinodale potrà rispondere al “bisogno della presenza salvifica di Dio”, tanto necessario da non dover essere proprio noi a disattendere e a soffocare. Per trasformare “segno dei tempi” in “segno di speranza”, siamo chiamati a superare rischi, pericoli e ostacoli che scoraggiano l’impegno e il nostro coinvolgimento operoso e fattivo. Anche noi, lo vedo a volte nei presbiteri e nei laici, siamo esposti a inevitabili tentazioni e rischi fuorvianti che potrebbero dirottarci verso una dolce putrefazione della nostra proposta pastorale, spesso insignificante, sclerotizzata in stereotipi da tempo mummificati, ma che ostinatamente continuiamo a ripetere. Da dove la tanto diffusa disaffezione dei battezzati verso le nostre assemblee domenicali?
Ogni Cammino è sempre insidiato. Il nemico numero Uno è sempre lui, il Satana. L’opera decisiva del Satana, coì come presentato dai Sinottici già all’inizio del ministero pubblico di Gesù di Nazareth, nel racconto delle Tentazioni nel deserto7, è di arrogarsi la parte di grande “Accusatore”8, con l’intento di indebolire la missione, provocare una forma di scoraggiamento, di “depressione” spirituale, morale, pastorale. Penso in particolare, e mista molto a cuore, ad un passaggio della parabola del seminatore quando Gesù, cosa molto singolare, spiega lui stesso: “Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati”9. Il Satana toglie dal cuore la Parola, cioè Cristo; di conseguenza, senza la Parola ci priva di ogni spinta profetica, oscura il futuro, impedisce la speranza, spegne la carità fraterna.
La strategia dell’Accusatore consiste nel tentativo di delegittimare, demotivare, svuotare di senso, svalutare e deprezzare ogni forma di impegno. “Non serve a nulla!” ti grida dentro. “Non ci provare tanto non riuscirai, non ne vale la pena, non cambierai mai, non cambierà nulla!”. Il corollario della depressione è quello che i medievali indicavano come acedia, accidia. Indefinitiva, il grande Accusatore persegue come fine ultimo la perdita della speranza e lo svilimento dell’agire.
Scrive J. Moltmann: “Dio ha elevato l’uomo, gli ha dato la prospettiva di ampi e liberi orizzonti, ma l’uomo rimane indietro e si scoraggia. Dio promette una nuova creazione di tutte le cose nella giustizia e nella pace, ma l’uomo agisce come se tutto fosse e rimanesse tale e quale. Dio lo onora facendogli la sua promessa, ma l’uomo non si crede capace di ciò che Dio si aspetta da lui. Questo è il peccato che minaccia nell’intimo il credente. Ciò che lo accusa non è il male che egli fa ma il bene che trascura, non i suoi delitti ma le sue omissioni lo accusano di mancare di speranza. Infatti questi cosiddetti peccati di omissione si fondano sempre sulla scarsa speranza e su una fede debole”10.
Risuona forte anche la riflessione di Giovanni Crisostomo: “Non è tanto il peccato che ci conduce alla perdizione, quanto piuttosto la mancanza di speranza”. Già nel Medioevo l’acedia o tristitia era annoverata tra i peccati contro lo Spirito Santo che conducono alla morte. Scrive ancora Moltmann: “Chi abbandona la speranza non deve necessariamente mostrare una faccia disperata; può trattarsi della semplice e silenziosa mancanza di significato, di prospettiva, di futuro, di scopo [ ] La speranza non prende le cose così come stanno, ma come cose che avanzano, si muovono e si trasformano nelle loro possibilità [ ] Il mondo è pieno di ogni cosa possibile, ossia di tutte le possibilità del Dio della speranza”11.
L’armonia della comunità, la forza dello Spirito
Cosa richiede l’attuale fase del Cammino perché sia davvero profetica? La profezia è trascinata dalla speranza. Per scardinare l’aspetto di manna dal cielo, di rassegnazione e di immobilismo , il filosofo Ernst Bloch scrive un libro: “Il principio della speranza”, nel quale argomenta che l’unico strumento in grado di mettere in moto lo sviluppo storico è la capacità dell’uomo di immaginare un non-essere-ancora e muoversi verso di esso per realizzarlo. Questa capacità è la speranza, non più intesa come stasi, ma come movimento. Una rivoluzione del significato, che ha portato anche Papa Francesco a riscrivere la speranza come potere di movimento: “La speranza è un vivere in tensione, sempre; sapere che non possiamo fare il nido qui: la vita del cristiano è “in tensione verso”. Se un cristiano perde questa prospettiva, la sua vita diventa statica e le cose che non si muovono, si corrompono”12.
E tempo della presa a carico delle decisioni per favorire e attuare la “conversione sinodale e missionaria” delle nostre comunità. La conversione non è una forma di aggiustamento o di adattamento, ma è “ripensare” metodi, stili, spazi, tempi, soggetti coinvolti, percorsi, contenuti, finalità e obiettivi. Lo stile comunitario della sinodalità, e il metodo missionario devono applicarsi ad un dinamico processo evangelizzazione del territorio, superando quello della sola sacramentalizzazione senza fede. Sacramentalizzare senza la fede è abusare della grazia di Dio!
Ho già scritto quanto la fase profetica richiede responsabilità personale e comunitaria rispetto a quello che Dio si aspetta da noi13. Ho anche esortato a esercitarsi su alcuni brani biblici, per acquisire conoscenza e maggiore dimestichezza con il processo profetico così come lo ritroviamo nell’esperienza biblica. I passi più espliciti e diretti a tale riguardo sono le sette Lettere che il Signore risorto indirizza alle sette Chiese dell’Asia Minore14. In buona sostanza, la profezia risponde alle tre istanze: da quale storia di salvezza veniamo; come la salvezza di Gesù oggi si fa storia nella vita reale delle nostre comunità; in che cosa riformare/rinnovare/ripensare le comunità, perché questa storia di salvezza possa ri-generare la forma più evangelica di comunità cristiana del terzo millennio.
Se ci lasciamo guidare dallo Spirito non sappiamo, a priori, verso dove andare: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito”15. E’ stata l’esperienza degli apostoli nel Cenacolo. Dopo la tragedia della Crocifissione si erano rinchiusi “per paura dei Giudei” (Gv 20,19). Dopo l’ascensione del Signore risorto “entrati in città salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui”16. Successivamente, Atti raccontano che “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano”17. Pertanto, ogni forma di vita comunitaria (famiglia, parrocchia, diocesi, Chiesa universale) se pervasa dallo Spirito Santo è per sua propria natura missionaria ed evangelizzatrice. E’ l’effusione dello Spirito che suscita nei singoli credenti e nell’intero popolo di Dio la sapienza della profezia e la forza della missione. E’ lo Spirito della profezia che apre le strade della missionarietà della Chiesa nel mondo. “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie” grida san Paolo18.
Il significato e la bellezza del Cammino sinodale è tutto qui: riscoprire e condividere il clima sinodale del Cenacolo (tutti perseveranti e concordi), invocare e favorire la permanente effusione dello Spirito della profezia per fare discernimento sulla vita di Chiesa (profezia ad intra) e sulla vita del mondo (profezia ad extra), e intraprendere con la forza dello Spirito (parresìa, cioè sfrontatezza e coraggio) la dirompente testimonianza missionaria19. “Dire “fase profetica”, significa per noi riattivare quella Pentecoste che fu un fatto di popolo, non di singoli. “Tutti” sentivano i primi predicatori parlare la propria lingua. E Pietro, spiegando l’incredibile accaduto, si disse convinto che era l’adempimento della profezia di Gioele: “Negli ultimi giorni – dice Dio – su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno”20 […] La profezia sinodale non è appannaggio di singoli, ma caratteristica dell’intero Popolo di Dio”21. Ma è davvero così nelle nostre comunità cristiane?
Questione di Chiesa e non di clero
Il Cammino sinodale se non è dell’intero popolo di Dio non sarà né cammino, né sinodale, né missionario, ma solo paravento di ciò che non interessa a nessuno o, ancora peggio, un disturbo che quanto prima dobbiamo risolvere. Qui si pone un problema spinoso: quale considerazione e ruolo di fatto stanno meritando i laici nella vita della comunità? Nell’incontro con la Scuola di formazione teologica della diocesi di Reggio Emilia nel novembre 2024, padre Lorenzo Prezzi affermava: “Il laico nella Chiesa ha patito e patisce ancora varie discriminazioni. È sostanzialmente inteso come un operaio ecclesiale chiamato a svolere dei compiti ma solo per delega. È considerato in fondo un minorenne spirituale. Ma non era così nelle comunità cristiane degli inizi che non conoscevano una contrapposizione preti-laici, ma tutti erano discepoli, santi e fratelli. Non è casuale che il termine laico non ci sia nel vocabolario biblico e sia raro anche nell’epoca patristica. La discriminazione verso i laici, considerati come la plebe governata e illetterata, comincia con l’arrivo nella Chiesa dei barbari, con l’usanza diventata comune di chiamare letterato il chierico, mentre il laico è illetterato. Si è trattato sostanzialmente di un adeguamento ai modelli della società civile. L’esito è stato il formarsi di una convinzione diffusa secondo cui l’azione dello Spirito Santo e della grazia operasse solo nei detentori della sacra potestà. Insomma il laico è rappresentato come colui che prende tutto e non dà nulla, portatore di una vocazione povera che si avvale di mezzi comuni e insufficienti per raggiungere la perfezione. Quanto detto esaspera e semplifica una condizione che nei fatti è sempre stata più complessa, ma serve per indicare una posizione ecclesiale minore e di scarsa qualità. Il concilio, assumendo la teologia del laicato e sviluppando la comune partecipazione al sacerdozio di Cristo ha definitivamente lasciato alle spalle la posizione marginale del laicato”22. La madre di tutte le priorità è l’urgenza di una nuova generazione di evangelizzatori laici. Sguardo prospettico e lungimirante In questa Fase profetica del Cammino vogliamo considerare la preziosa partecipazione di tanti laici che nelle molte comunità in questi anni del Cammino sinodale hanno offerto volentieri la disponibilità a dialogare in una conversazione spirituale profonda e partecipativa. Non vogliamo né dobbiamo disperdere questa risorsa proprio nel momento decisivo del Cammino, perché “la profezia sinodale non è appannaggio di singoli, ma caratteristica dell’intero Popolo di Dio”.
Non sarà possibile testimoniare il vangelo della speranza senza incontrare sul territorio chi lo vive e lo abita quotidianamente, mentre restiamo rinchiusi per paura anche noi nel nostro caldo e rassicurante “cenacolo” dell’eletto gruppo parrocchiale dei pochi praticanti. Abbiamo omologato ormai da troppo tempo la categoria di “parrocchia” con i luoghi, gli spazi, e le attività all’interno delle strutture, dimenticando che dire “parrocchia” è dire “comunità” di persone che vivono la quotidianità negli spazi vitali della famiglia, della strada, del lavoro, della scuola, del dolore e dei lutti, di riti senza liturgia, di sacralità laica senza preti, di diffusa religiosità pagana e idolatrica. Né la teologia, né i documenti magisteriali, né la generosità dei singoli pastori, potrà pretendere di affrontare da soli le sfide del prossimo futuro. Vi sono ancora nelle immediate vicinanze della comunità cristiana competenze laicali di alto profilo. Se ciascuno dei fedeli e dei credenti anonimi che guardano con interesse al Vangelo potessero prendere parola si potrebbe sperare per un indirizzo ecclesiale più evangelico e più autorevole rispetto alle attuali sfide di civiltà. Cosa ci sta dicendo un libro sulla Bibbia primo in classifica in Italia nel 2024? Mi riferisco al libro di Aldo Cazzullo “Il Dio dei nostri padri”. Riporto un passaggio interessante riguardo all’impatto che ha avuto sull’opinione pubblica: “Compra e legge una «biografia di Dio» – com’è stato definito il libro di Cazzullo – chi sente di trovare nelle sue pagine un linguaggio e un mondo verso il quale sperimenta interesse e attrazione, forse nostalgia, non certo indifferenza o estraneità”23. Non dice nulla tutto questo? C’è una forma di attesa non facilmente intercettata dai nostri propositi pastorali.
Tutto ciò considerato, ritengo indicare, tra le diverse priorità che possono favorire la conversione sinodale e missionaria della nostra diocesi, l’urgenza della immissione e formazione di una nuova generazione di laici, impegnati nella partecipazione corresponsabile e nella guida della comunità, nella formazione alla fede in tutte le fasce d’età, nell’evangelizzazione a tutto campo. Possiamo avvalerci della provvidenziale e qualificata attività della Scuola diocesana di formazione, ma anche dello stesso Istituto teologico leoniano di Anagni con le variegate proposte formative di Aggiornamento on-line per chiunque (presbiteri, operatori pastorali, diaconi, IRC). Ma non è sufficiente assicurare una formazione apicale di alcuni, se poi tutti gli altri operatori non beneficiano di questa formazione, mentre di fatto continuano ad operare nelle parrocchie secondo mentalità e prassi pastorali ormai obsolete e afone. Tale formazione, deve necessariamente prevedere e riguardare soprattutto una nuova generazione di operatori pastorali a cui pensare per ogni ambito della vita parrocchiale. Il più delle volte si tratterà forse di cimentarci con un’opera analoga a quella del Dio creatore, in quanto dovremo iniziare a fare qualcosa “ex nihilo”, suscitando una prima disponibilità dei battezzati rimasti ai margini o ignorati ma non ignoranti, disponibili se interpellati a collaborare per la vita della comunità.
Questione di profezia
Cari amici, la profezia biblica non mira a forme di “aggiustamento” della vita del Popolo di Dio, né di riforma di alcuni aspetti. La profezia biblica parla di “conversione”, di inversione a “U” a cui ci obbliga la voce del navigatore che è lo Spirito Santo. Si tratta di tornare indietro, e ripartire in una direzione completamente diversa, nuova, adeguata alla meta che desideriamo raggiungere. La conversione è una forma di “inversione” di marcia, un ripensamento. Ri-pensare” significa ri-vedere, vedere in modo diverso, pensare in modo completamente cambiato, nuovo, inedito, profetico appunto. Viene in aiuto l’intervento con cui Gesù invita a non mettere delle toppe sulle questioni consunte, sfilacciate, logore. Si rischierebbe solo uno strappo peggiore. “Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. 22E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!”24. Accogliamo la profezia di Gesù, compimento ultimo e definitivo di tutte le profezie: “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova [ ]. E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. E soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e vere”. E mi disse: “Ecco, sono compiute!”25. In questi versetti il termine “nuovo/nuova” ricorre quattro volte, e sempre traduce l’aggettivo greco καινός, che significa: insolito, inaspettato, straordinario, strano, singolare (a differenza di νέος che significa nuovo nel senso di copia di un modello già esistente. La profezia è qualcosa di inedito e di sorprendente. Ce lo ricorda anche Pablo Neruda con questa bella poesia sulla Speranza:
Speranza
Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano
inonda col tuo canto i tristi cuori.
Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi.
Tu che riempi l’anima di bianche illusioni.
Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni
in quelle deserte, disilluse vite
in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente,
ed in quelle che sanguinano le recenti ferite.
Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori
quale timido stormo sprovvisto di nido
, ed un’aurora radiante coi suoi bei colori
annuncerà alle anime che l’amore è venuto.
Apriamo il cuore per amare la Chiesa più di noi stessi, eleviamola mente per rendere spedito il nostro cammino sui passi dello Spirito, apriamo le braccia per operare come artigiani del Vangelo, per sognare e disegnare insieme il modello di Chiesa del terzo millennio.
Grazie.
+ Gerardo Antonazzo
Note
1 Mc 3, 13-19
2 L. BRUNI, Il vangelo secondo Marco. Una rilettura, Milano 2022.
3 MESSALE ROMANO, Preghiera eucaristica V1.
4 CEI, Lineamenti, Prima Assemblea Sinodale delle Chiese che sono in Italia, Roma 15-17 novembre 2024.
5 FRANCESCO, Spes non confundit, 7.
6 Lc 12, 56: “Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?”.
7 Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,1-13 8 Ap 12,10: “E’ stato precipitato l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte”.
9 Lc 8,11-12.
10 J. MOLTMANN, Teologia della speranza, Brescia 1976, p. 16.
11 Ibidem, pp. 17-19.
12 PAPA FRANCESCO, Discorso 29 ottobre 2019.
13 G. ANTONAZZO, Lettera del Cammino sinodale/15.
14 Ap 2-3.
15 Gv 3,8.
16 At 1,13-14.
17 At 2,1-2.
18 1Ts 5,19-20.
19 Cfr. G.ANTONAZZO, Lettera Cammino sinodale/16, p.2
20 At 2,17-18; cf. Gl 3,1-2.
21 CEI, Strumento di lavoro per la Fase profetica, p. 5-6.
22 L. PREZZI, Per una Chiesa profetica, in Settimana News 31 dicembre 2024.
23 F. Ognibene, Il fenomeno “Dio dei nostri padri”, in Avvenire del 15 gennaio 2025.
24 Mc 2, 21-22.
25 Ap 21,1-2;5-6.
Per leggere e/o scaricare il testo in PDF clicca qui